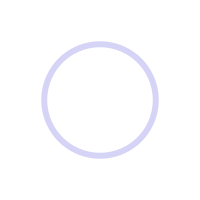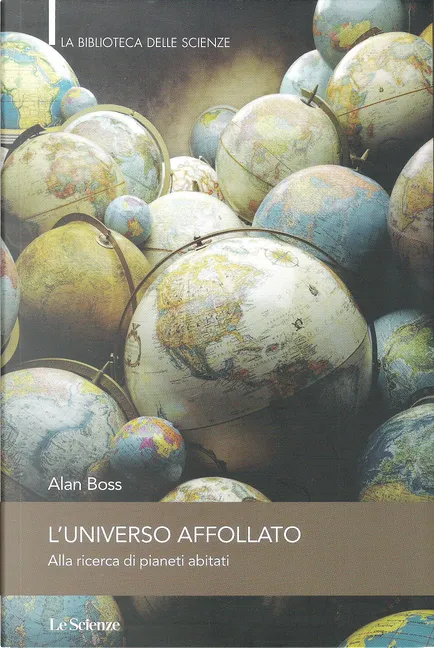
Tempo di lettura:
6h 10m
Il 6 ottobre 1995 un astronomo svizzero dell'Osservatorio di Ginevra, Michel Mayor, annuncia a Firenze una formidabile scoperta: il suo gruppo ha individuato il primo pianeta extrasolare, un gigante grande la metà di Giove in orbita intorno alla stella 51 Pegasi con un sorprendente ciclo orbitale di appena quattro giorni. Il 23 novembre la scoperta viene pubblicata su «Nature», aprendo ufficialmente una nuova era nella storia dell'astronomia osservativa e confermando - come ci si aspettava - che il Sole non è certo l'unica stella circondata da un sistema planetario.
È da qui che prende le mosse la storia - esaltante, struggente, a volte frustrante - ricostruita da Alan Boss in L'universo affollato, il libro in edicola con il numero di gennaio di «Le Scienze». Ricercatore presso il Dipartimento di magnetismo terrestre della Carnegie Institution, a Washington, Boss è uno tra i maggiori esperti mondiali di teorie della formazione planetaria, e ha vissuto in prima persona la corsa al primo pianeta extrasolare, trascorrendo poi i quindici anni che ci separano da quella scoperta nel cuore della neonata comunità degli «esoplanetologi». Così se Boss sceglie, per il dipanarsi della sua narrazione, l'arida cadenza temporale degli eventi, in realtà non c'è pagina da cui non traspaia la formidabile passione di chi dedica la vita alla ricerca di pianeti abitabili al di fuori del sistema solare.
Già, perché gli astronomi non si sono certo accontentati dei primi successi, rapidamente seguiti all'annuncio di Mayor. L'obiettivo finale è, come dichiara l'autore, scoprire «quanti sono i pianeti simili alla Terra nel nostro vicinato, la Via Lattea». Di più: sapere se da qualche parte, qui intorno, ci sono corpi celesti che ospitano forme di vita. E presto potremmo arrivare almeno al primo obiettivo, grazie anche a due telescopi spaziali che si stanno confrontando in questa affascinante corsa: l'europeo CoRoT, lanciato nel 2006 per studiare la struttura delle stelle ma rivelatosi un ottimo strumento per l'osservazione di pianeti di tipo terrestre; e lo statunitense Kepler, progettato specificamente per individuare e catalogare pianeti abitabili, messo in orbita dalla NASA il 7 marzo scorso.
Sono almeno tre i racconti che si intrecciano nelle pagine di Boss: uno è la straordinaria progressione delle scoperte di nuovi pianeti, in incessante accelerazione; un altro è l'affinamento delle tecniche di osservazione, dalla misurazione della riduzione della luminosità di una stella mentre un pianeta le passa davanti lungo l'orbita - i cosiddetti «transiti» planetari - allo sfruttamento delle microlenti gravitazionali, che ci riporta a quel «telescopio di Einstein» che abbiamo pubblicato in ottobre; e infine c'è il continuo perfezionamento degli strumenti osservativi, che sta alimentando quella accelerazione.
C'è poi anche un quarto, sofisticato registro di lettura in L'universo affollato, che Boss preannuncia fin dal Prologo. È la battaglia per la supremazia su un terreno di ricerca nuovo e importante, che il planetologo statunitense legge con un notevole rammarico per la deprimente evoluzione dei budget scientifici della NASA. In questo scontro (un po' al ribasso, se si pensa ai bilanci delle rispettive agenzie spaziali...) tra Europa e Stati Uniti - rileva Boss - la prima «è in vantaggio di oltre due anni». E c'è da scommettere che, vedendo già minacciata la propria supremazia in fisica delle particelle dalla costruzione di LHC, la comunità scientifica d'oltre Atlantico non abbia nessuna intenzione di tollerare un ulteriore ridimensionamento del ruolo di dominatrice assoluta della ricerca che ha avuto almeno negli ultimi settant'anni.
Frattanto, come si legge a pagina 34, il numero dei pianeti extrasolari ha superato quota 400, e gli astronomi impegnati nella ricerca di pianeti simili alla Terra si sono riuniti a Barcellona in settembre per definire una strategia comune. Il tempo che ci separa dalla scoperta di un pianeta roccioso, con la superficie parzialmente coperta di acqua allo stato liquido e un'atmosfera contenente ossigeno potrebbe non essere molto. E allora anche la celebre domanda di Enrico Fermi - dove sono tutti quanti? - potrebbe cominciare a trovare risposte.